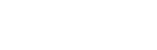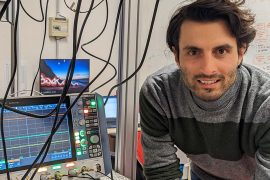Il monitoraggio e la protezione della biodiversità sono sempre più al centro dell’attività di ricerca. Anche in Ateneo questo tipo di studi viene svolto tanto in realtà geograficamente vicine quanto in aree molto lontane. Per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema sono state istituite alcune ricorrenze, tra cui la Giornata mondiale della fauna selvatica, voluta dalle Nazioni Unite nel 2013, per indirizzare ogni 3 marzo l’attenzione sulla conservazione degli animali e delle piante selvatiche. La riflessione interessa da vicino anche gli stessi ricercatori, chiamati a utilizzare metodologie che non creino danno agli animali oggetto delle rilevazioni.
Una buona pratica viene dagli studi condotti da Sara Fratini e Alessio Iannucci, ricercatori del Dipartimento di Biologia rispettivamente in Zoologia ed Ecologia, con il supporto degli assegnisti Lorenzo Ballini e Giorgia Staffoni: nelle loro indagini hanno utilizzato il DNA ambientale, una tipologia di monitoraggio innovativa e molto efficace per individuare la presenza di specie rare ed elusive, difficili da rilevare con attività sul campo, e descrivere la composizione di intere comunità presenti in un dato ambiente.
In un caso la ricerca ha riguardato la presenza della lontra europea in Liguria (con un finanziamento della Regione Liguria e dell’ARPAL), nel secondo il focus ha interessato le specie a rischio sull’Appennino tosco-emiliano. Questa seconda attività è stata svolta nell’ambito del Centro nazionale per la ricerca National Biodiversity Future Center (NBFC) finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca con fondi dell’Unione Europea nell’ambito del programma #NextGenerationEU (PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).
Dottoressa Sara Fratini, cosa caratterizza il monitoraggio del DNA ambientale?
“Vengono raccolti campioni ambientali – acqua, suolo, aria – del territorio in cui vivono l’animale o una comunità di animali, alla ricerca di tracce di DNA rilasciate nell’ambiente da peli, cellule epiteliali e feci. L’utilizzo del DNA ambientale è sempre più frequente: sia perché non è invasivo e quindi non disturba gli animali, sia perché garantisce un controllo molto esteso e capillare delle specie presenti nella zona oggetto dell’indagine, a fronte di una permanenza sul campo relativamente breve”.
Cioè?
“Per monitorare la presenza delle lontre nella Liguria occidentale, che si credevano non più presenti nella zona dagli anni Ottanta, è stata sufficiente la raccolta di pochi litri di acque fluviali, avvenuta in qualche ora. Poi, certo, per le analisi nei laboratori del dipartimento è stato necessario molto più tempo, ma abbiamo ridotto di tanto il disturbo nell’ecosistema provocato dalla nostra attività di ricerca sul campo, a fronte di numerosissimi dati riguardanti anche specie di cui ignoravamo la presenza – come alcuni anfibi – e assai importanti per definire il livello di biodiversità”.
Dottor Alessio Iannucci, il DNA ambientale si è rivelato utile anche nei monitoraggi sull’Appennino tosco-emiliano?
“Certo. Con un singolo campionamento per sito siamo riusciti a registrare circa 1200 animali. Registrare così tante specie in contemporanea avrebbe richiesto numerosi sopralluoghi se avessimo seguito metodologie più classiche. La ricerca ha interessato vertebrati e invertebrati – di acqua dolce e non – per misurare l’efficacia della protezione garantita dalla Rete Natura 2000, il principale strumento della politica dell’Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Con questo obiettivo abbiamo messo a confronto la presenza delle specie in ambienti protetti e non protetti”.
Cosa è emerso?
“L’elemento più importante è il buon livello di biodiversità che contraddistingue quella parte della Toscana. Per quanto riguarda le specie di acqua dolce, i siti protetti sono popolati da un maggior numero di specie classificate a rischio, a testimoniare un apporto positivo della Rete Natura 2000”.