La pellicola in Super 8, recuperata e digitalizzata dal Laboratorio Multimediale di Ateneo, ha una durata di circa cinquanta minuti e racconta in modo molto efficace e non retorico il passaggio dalla istituzione manicomiale – intesa come luogo di costrizione deputato al “mantenimento dell’ordine sociale” – all’apertura dei centri di igiene mentale e delle case-famiglia, luoghi di cura e di presa in carica del malato. In particolare, il documentario racconta l’esperienza di una piccola comunità in una frazione del Comune di Lamporecchio – Orbignano – in cui alcuni ex degenti dell’ospedale psichiatrico di Pistoia sono stati accolti per tre mesi, prima di essere avviati ai servizi sul territorio. In pratica, con la collaborazione degli enti locali e di comitati cittadini, fu creata una “comunità protetta”, cioè una struttura intermedia tra ospedale e casa-famiglia, in cui gli ospiti potevano gradualmente acquisire autonomia e imparare ad autogestirsi.
Si trattò di un esperimento clinico ma anche sociale – e qui sta il valore di questa pellicola – perché la diffidenza e la preoccupazione iniziali dei cittadini di Orbignano lasciarono il posto alla tolleranza, all’apertura e all’abbandono dei pregiudizi verso i malati psichiatrici.
Rolando Paterniti è il docente di psichiatria che condusse la sperimentazione: racconta così questa esperienza.

«Era il 1982 e la legge n° 180 del maggio 1978 non era ancora stata applicata nonostante fossero passati 4 anni dalla sua approvazione. Si cominciavano a creare i nuovi servizi psichiatrici nel territorio, al di fuori del manicomio; vennero istituiti gli ambulatori territoriali i cosiddetti Centri di igiene mentale (CIM) e i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) collocati all’interno degli ospedali generali come qualsiasi altro reparto di medicina. Questi diventavano i nuovi luoghi deputati alla cura e all’assistenza dei malati di mente.
Il problema che si poneva alla psichiatria nei primi anni ’80 era dunque quello di occuparsi delle persone che avevano passato molti anni in manicomio sviluppando, oltre alla malattia mentale, anche la regressione e la dipendenza dagli altri, tipiche della cosiddetta sindrome da istituzionalizzazione: questi soggetti non erano in grado di provvedere a sé stessi in maniera autonoma e avevano perso l’abitudine di vivere in ambienti comuni dell’esistenza.
Il progetto prevedeva l’uscita dal manicomio e l’inserimento nelle case-famiglia (cioè abitazioni condivise da più pazienti ed assistite da educatori, infermieri e assistenti sociali). La USL Valdinievole aveva assegnato alla Psichiatria alcuni edifici nella zona di Borgo a Buggiano che erano stati restaurati per ospitare due case-famiglia e un centro occupazionale. Queste nuove strutture erano destinate ai pazienti delle Ville Sbertoli che non potevano rientrare nelle loro famiglie. Dopo lunghe e approfondite riflessioni tra tutti gli operatori venne messo a punto un progetto chiamato camera di decompressione che aveva lo scopo di preparare quei pazienti alla nuova vita che avrebbero condotto nelle case-famiglia.
L’Associazione intercomunale della Valdinievole e il Comune di Lamporecchio ci misero a disposizione una vecchia scuola dismessa nella frazione di Orbignano e lì cominciò l’avventura. Una decina di pazienti (che erano già stati informati e preparati nei mesi precedenti) vennero trasferiti nella scuola di Orbignano che rappresentava un ambiente nuovo per loro ma ancora sufficientemente protetto. L’esperienza di Orbignano si svolse nell’estate del 1982. Prima avevamo incontrato gli abitanti del posto per spiegare cosa sarebbe accaduto di lì a poco e vennero fatte assemblee tra gli amministratori pubblici, la popolazione e noi operatori della psichiatria. Non fu facile convincere gli abitanti della zona che temevano l’arrivo dei matti furiosi ma alla fine tutto andò bene».
Come nacque l’idea di girare un documentario?
«Nel mese di luglio 1982 giunsero alla scuola di Orbignano due giovani insegnanti di scuola – Averardo Brizzi e Gabriele Cecconi – che erano impegnati nel cinema e avevano già realizzato alcuni documentari. Dissero di essere interessati a quanto si faceva lì e proposero di riprendere le attività di riabilitazione. Ottenuto l’assenso di tutti (pazienti e operatori) cominciarono a venire spesso alla scuola di Orbignano e a filmare quello che accadeva.
Fecero interviste ai pazienti e agli operatori, parlarono con gli abitanti della zona di Lamporecchio e anche con quelli di Borgo a Buggiano (dove si sarebbe conclusa l’esperienza), raccolsero le voci di tutti, favorevoli e contrari, parteciparono alle assemblee pubbliche e alla fine produssero quel docufilm L’Albero Storpio che rappresenta una eccezionale testimonianza di quel periodo. Sono grato agli sforzi di Averardo e di Gabriele perché la loro opera mi consente ancora oggi di spiegare ai giovani psichiatri che cosa era il manicomio e come è cambiata l’assistenza psichiatrica negli ultimi 40 anni. Infatti nelle lezioni agli specializzandi di psichiatria faccio vedere L’Albero Storpio perché ritengo che sia fondamentale comprendere la logica perversa che stava alla base della grande istituzionalizzazione manicomiale».
Un aspetto interessante di questo documentario riguarda gli effetti sociali della convivenza tra “sani e malati”. Crede che la percezione della malattia mentale sia cambiata da dopo la legge Basaglia?
«La percezione della malattia mentale oggi è sicuramente cambiata rispetto a 40 anni fa, ma c’è ancora molto da migliorare. La gente è sempre più consapevole che i gesti folli vengono commessi da persone considerate sane, che non sono affette da malattia mentale. La sofferenza psichica, nelle sue varie forme, si è diffusa a tutta la popolazione e finalmente si è cominciato a capire quanto sia falsa l’equivalenza matto=violento. Purtroppo, oggi i comportamenti violenti e aggressivi sono talmente diffusi tra la popolazione normale che non si attribuiscono più alla malattia mentale. Ma tutto ciò non è un bene. Infatti non sono particolarmente ottimista in proposito.
Ai tempi dell’esperienza di Orbignano c’era più dibattito e più partecipazione sui temi della malattia mentale e c’erano anche più risorse di denaro e di personale destinate alla psichiatria. Tuttavia, sono fiducioso che il processo di superamento dell’Ospedale Psichiatrico che si è messo in moto 50 anni fa sia giunto al traguardo e non vedo il rischio di ritorni indietro. Però è necessario tenere viva l’esperienza del passato e conoscere la storia di chi ci ha preceduto per evitare di commettere gli stessi errori.
L’Albero Storpio può contribuire ad apprendere dall’esperienza e a migliorare i livelli di cura e assistenza di quella strana e dolorosa esperienza esistenziale che chiamiamo malattia mentale.
Gabriele Cecconi ha scritto e diretto questo docufilm insieme ad Averardo Brizzi.
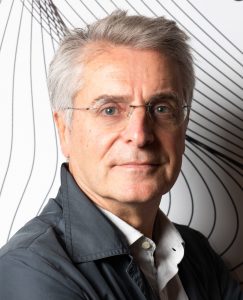
Come è nato questo progetto?
«Il documentario L’albero storpio (Super 8, 1982, 58 min.) è il terzo film scritto e diretto da Averardo Brizzi e me. Avevamo iniziato a realizzare piccoli film in super 8 con gli studenti, (il primo fu Uno di noi del 1976 sul tema della emarginazione di uno studente), convinti che la scuola avesse il compito non solo di educare a leggere le immagini, ma anche quello di permettere agli studenti di scrivere con le immagini. Eravamo convinti che la scuola era troppo curriculare, finalizzata unicamente a trasmettere le nozioni delle singole discipline, trascurando il mondo emotivo dei ragazzi che avevano bisogno anche di comunicare il loro vissuto, le speranze, le paure, le gioie e le tristezze della loro adolescenza. Quel film ebbe un certo successo alla Biennale del cinema dei ragazzi di Pisa, cominciammo ad essere conosciuti ed apprezzati (a scuola ci chiamavano i tavianini perché eravamo sempre insieme e amavamo i film dei fratelli Taviani), e così arrivarono le richieste di girare un filmato sull’esperienza delle case-famiglia dopo la legge Basaglia del 1978»
Perchè il titolo L’albero storpio?
«La scelta fu dovuta alla lettura della poesia di Bertolt Brecht “Brutti tempi per la lirica” che ci colpì molto perché ben rappresentava la motivazione sociale che stava alla base della sua opera, a favore degli ultimi e degli esclusi, che era anche quella che spingeva noi a “scrivere” con la macchina da presa su tematiche sociali, con l’occhio sempre attento alle fasce più deboli della società. La poesia dice: Lo so: piace soltanto/ chi è felice. La sua voce/ volentieri la si ascolta. Bello è il suo viso./ L’albero storpio nel cortile/ denuncia il cattivo terreno, ma/ chi passa gli dà di storpio,/ e con ragione».
Come ricorda la realizzazione del documentario?
«Furono giornate di riprese molto intense e coinvolgenti, in particolare quelle alle Ville Sbertoli, sede dell’Ospedale Neuropsichiatrico della Provincia di Pistoia. Ci fece da guida il dott. Rolando Paterniti, un giovane psichiatra appassionato come noi, con cui condividevamo gli stessi ideali. Bei tempi, quelli. Io realizzai le riprese, Averardo le interviste. Il montaggio sempre insieme, pomeriggi passati, di ritorno da scuola, a tagliare e cucire la pellicola con la moviola e la taglierina. L’albero storpio fu molto apprezzato dalla Regione Toscana che organizzò diverse proiezioni del documentario con successivo dibattito pubblico sul tema dell’applicazione della legge Basaglia. Sulla scia di questo successo ci arrivò la richiesta di realizzare un vero e proprio film sulla strage del Padule di Fucecchio dell’agosto 1944, e così girammo Padule, ricordo di una strage (1986, 70 min, 16 mm.) con doppiaggio e post-produzione a Cinecittà, che vinse diversi premi e fu trasmesso da Rai 3. Qui mi fermo perché è qui che Averardo è venuto a mancare. Di lui conservo il ricordo di una grande amicizia, purtroppo troncata dalla sua morte prematura. Con lui è scomparso non solo l’amico, ma anche un insegnante entusiasta e un appassionato regista».





