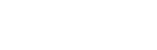La Giornata Mondiale della Libertà di Stampa è stata proclamata dalle Nazioni Unite nel 1993, in occasione dell’anniversario della Dichiarazione di Windhoek (redatta nel 1991) sulla promozione di una stampa africana indipendente e pluralistica. Da oltre 30 anni la Giornata continua a ricordare la necessità di tutelare la libertà di parola sancita dall’Articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948. Rappresenta da un lato un momento per promuovere azioni concrete e iniziative finalizzate a difendere la libertà della stampa, ma dall’altro è anche un’opportunità per valutare la situazione della libertà di stampa nel mondo.
Quando pensiamo alla libertà di stampa siamo soliti, giustamente, volgere lo sguardo ai Paesi non democratici, dove questo diritto è represso e incanalato verso un’informazione totalmente controllata. Tuttavia, queste pur doverose sensibilità rischiano di distogliere la nostra attenzione da altri rischi che la libertà di stampa corre in tutto il mondo, anche in Paesi che potrebbero sembrare fuori pericolo. Ci riferiamo ad alcune tendenze che caratterizzano ormai da tempo il mondo dell’informazione.
Innanzitutto, un modello redistributivo delle risorse economiche che favorisce non più di 5 piattaforme digitali, meglio note con l’acronimo GAFAM – Google, Amazon, Facebook (ora Meta), Apple, Microsoft – che ormai da anni raccolgono ben oltre l’80% del mercato pubblicitario mondiale, la più rilevante fonte di finanziamento della stampa da quando la ricchissima e disordinata offerta digitale ha convinto tutti noi che le news debbano essere gratuite!
Dunque, poche aziende che si limitano a distribuire informazioni guadagnano enormemente più di tutte quelle che producono informazioni. In altri termini, il giornalismo deve produrre sempre di più, per rispondere a una concorrenza planetaria, ma con sempre meno risorse. Ovviamente, la qualità non può che risentirne, dovendo affidarsi a professionisti chiamati a intensificare e velocizzare la loro produttività a scapito dell’essenza del lavoro giornalistico: controllare la veridicità delle informazioni e riuscire a contestualizzarle.
Tutto questo in un ecosistema informativo caratterizzato dalla disintermediazione, per cui in rete ci siamo tutti e tutti insieme: le fonti che producono gli eventi, ciascuno di noi consumatori di informazioni, oltre ai giornalisti, che fino a ieri avevano il controllo esclusivo della notiziabilità. Questa compresenza determina quel sovraccarico informativo che ciascuno sperimenta tutti i giorni, in cui è più facile che si annidi il disordine informativo in cui si muovono con disinvoltura spregiudicati avventurieri, interessati al clickbaiting, cioè indurci a cliccare per motivi economici sulle notizie più eclatanti, casomai inventandosele oppure edulcorandole, grazie anche al ricorso sempre più intenso all’intelligenza artificiale. Oppure a inserire fake news tese a disinformare per fini ideologici e politici. Non a caso, il Global Risks Perception Survey 2023-24 del World Economic Forum ritiene la disinformazione il maggiore rischio per il nostro immediato futuro, addirittura più di quanto non sia il cambiamento climatico.
Ne consegue l’esigenza di attivare processi di educazione civica finalizzati a implementare l’alfabetizzazione digitale; non intesa soltanto come addestramento a tecnologie continuamente cangianti, ma anche come capacità di saper valutare l’affidabilità delle fonti da cui riceviamo le notizie.
Un addestramento ineludibile, perché senza una buona informazione viene meno la coesione sociale che garantisce la sana convivenza fra le persone.
La stampa è un bene pubblico. Averla libera e indipendente dovrebbe interessare tutti noi e non soltanto gli addetti ai lavori.