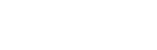Il 22 maggio ricorre la Giornata mondiale della biodiversità, indetta dalle Nazioni Unite per celebrare la ricchezza della vita – a livello di ecosistemi, specie e geni – sul nostro pianeta. Istituita dalle Nazioni Unite nel 2000, ha lo scopo di aumentare la comprensione e la consapevolezza dei problemi della biodiversità e di ricordare l’adozione del testo della Convention on Biological Diversity (CBD), firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.
“La biodiversità è alla base della vita sulla Terra, regola gli equilibri tra le specie, contribuisce alla salute ed alla resilienza di tutti gli ecosistemi” spiega Antonella Buccianti, docente di Cicli geochimici e dinamica dei sistemi complessi del Dipartimento di Scienze della Terra. “In particolare, i fiumi sono attentamente monitorati dall’Unione Europea in seguito alla Natural Restoration Law: approvata nel luglio del 2024, mira a identificare e rimuovere le barriere che influenzano la connettività fluviale, e quindi la biodiversità, proponendo di restaurare entro il 2030 in Europa almeno 25mila chilometri di fiumi in condizioni di libertà di scorrimento”.
Il livello di biodiversità nei fiumi è finito sotto la lente di ingrandimento anche degli scienziati Unifi, nell’ambito del centro nazionale National Biodiversity Future Center (NBFC), finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca con fondi dell’Unione Europea nell’ambito del programma #NextGenerationEU (PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Il gruppo di ricerca coordinato da Buccianti si è focalizzato appunto sullo studio dei bacini fluviali, analizzando i meccanismi che modificano la composizione chimica dell’acqua: litologia dell’area, caratteristiche morfologiche e climatiche, uso del suolo e impatti antropici.
“Il progetto – prosegue la docente – ha visto un monitoraggio integrato del fiume Ombrone, nel suo tratto grossetano. Sono state analizzate circa 120 acque fluviali, prelevate in 40 siti selezionati durante tre campagne di campionamento rappresentative di diverse condizioni idrologiche. L’ultima campagna si è svolta a settembre 2024 a seguito di un evento di pioggia particolarmente intenso, in cui contestualmente all’analisi chimica delle acque è stata monitorata anche la loro composizione microbica”.
Attualmente, i ricercatori stanno confrontando i dati chimici e la composizione microbica delle acque, per identificare eventuali connessioni tra fattori idrologici, geochimici e biologici. L’obiettivo è comprendere i meccanismi di autoregolazione che legano geodiversità e biodiversità, oltre a valutare gli effetti che le sempre più frequenti siccità e inondazioni, legate ai cambiamenti climatici, possono avere su tali equilibri. Acquisire queste conoscenze è essenziale per caratterizzare la resilienza degli ambienti fluviali al fine di identificare strategie di adattamento efficaci per la loro protezione.
L’approccio multidisciplinare adottato nel progetto costituisce un modello applicabile anche ad altri bacini fluviali italiani ed europei, in linea con gli obiettivi del PNRR e con le strategie europee per sostenere la resilienza degli ambienti fluviali.
“I corsi d’acqua – afferma la docente – costituiscono una rete fondamentale per il territorio, nonché un vasto e diversificato numero di habitat per migliaia di specie viventi. Tuttavia, come riportato dai reports scientifici del WWF, oggi il 41% dei fiumi italiani non versano in buone condizioni ecologiche e il 46% dell’ittiofauna è relativo a specie alloctone”.
“Gli habitat fluviali si diversificano sensibilmente lungo il corso, con vegetazione caratteristica e specie legate ad ambienti differenti. Purtroppo – conclude Buccianti – molti ecosistemi sono divenuti rari per la gestione dei fiumi intesi più come ‘condotte’ in cui l’acqua deve scorrere senza ostacoli, piuttosto che come ecosistemi complessi, che nella loro funzionalità hanno anche quella di rallentare la corsa dell’acqua e contenere i tempi delle piene a valle”.