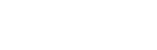La popolazione mondiale ha superato da poco gli 8 miliardi di abitanti e, stando alle proiezioni, continuerà a crescere ancora per diversi decenni. Ma non ovunque allo stesso modo. Mentre alcune aree del pianeta si preparano a un forte incremento demografico, altre stanno vivendo da anni un rallentamento della crescita, se non addirittura un calo. Una su tutte l’Italia.
La Giornata mondiale della popolazione, istituita nel 1989 dal Consiglio direttivo del Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite e celebrata ogni 11 luglio, offre l’occasione per riflettere sull’evoluzione demografica che caratterizzerà i prossimi anni, sia in Italia che nel mondo.
“Sappiamo con buona certezza che la popolazione mondiale continuerà ad aumentare fino alla fine del secolo, probabilmente superando i 10 miliardi di abitanti” spiega Raffaele Guetto, docente di Demografia presso il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni ‘G. Parenti’ (DiSIA). “Tuttavia, non crescerà all’infinito, ma affronterà un rallentamento progressivo che dovrebbe portare la popolazione globale a stabilizzarsi intorno al 2100”.
La crescita, però, non sarà omogenea. Mentre l’Europa, il Nord America e la Cina mostrano già segnali di stagnazione o di declino, la gran parte dell’incremento futuro sarà trainata dall’Africa, che da sola potrebbe passare da circa 1,5 a oltre 4 miliardi di abitanti nel giro di qualche decennio. Anche alcuni Paesi dell’Asia, come l’India, continueranno a crescere, ma più lentamente. Nel frattempo, il peso demografico dell’Europa continuerà a ridursi. Nel 1950, l’Europa rappresentava circa il 22% della popolazione mondiale. Entro il 2100, questa quota sarà attorno al 5%.
Se l’Europa non cresce, l’Italia si “restringe”. Il nostro Paese, infatti, presenta un tasso di fecondità da oltre 40 anni inferiore ai 1,5 figli per donna e nel 2024 si attesta attorno a 1,18, tra i più bassi del continente e del mondo. “Nello stesso periodo, Stati europei come Svezia e Danimarca hanno mantenuto tassi di fecondità più vicini ai 2 figli per donna, per quanto anche questi paesi stiano recentemente sperimentando un inatteso calo della fecondità, con tassi di fecondità, nel 2024, attorno ai 1,5. Sembra poco, ma queste differenze contano. Infatti, mentre in tanti paesi la popolazione è ancora stabile, in Italia risulta sensibilmente in calo: il numero di decessi supera quello delle nascite da almeno trent’anni e senza il contributo dell’immigrazione la nostra popolazione avrebbe iniziato a diminuire già negli anni ’90. Le previsioni dell’ISTAT parlano chiaro: entro il 2080, la popolazione italiana sarà diminuita di diversi milioni di abitanti”.
Secondo Guetto, “un calo demografico in sé non è necessariamente negativo: meno persone può significare una pressione inferiore sulle infrastrutture, più spazio e meno inquinamento. È l’invecchiamento a preoccupare, perché una popolazione meno giovane significa una minore forza lavoro, con risvolti molto impattanti in termini di sostenibilità del welfare e della spesa pensionistica. Senza contare le crescenti difficoltà che il sistema sanitario nazionale può incontrare nel fornire servizi e prestazioni a una popolazione sempre più anziana”.
Ma perché si fanno sempre meno figli? È una scelta libera o una conseguenza di ostacoli concreti?
Gli studi condotti dai ricercatori DiSIA dimostrano che c’è una distanza significativa tra il numero di figli desiderati e quelli effettivamente avuti. In Italia questo divario è tra i più alti d’Europa. Il problema non è solo culturale, ma spesso strutturale: instabilità lavorativa, soluzioni abitative costose, assenza di servizi per l’infanzia. In queste condizioni, molte coppie rinunciano a fare figli.
“È pur vero – aggiunge il docente – che in Italia come in gran parte dei paesi occidentali sono cambiate le scelte culturali ed è aumentata l’insicurezza verso il futuro, non solo in termini economici. Pandemia, cambiamento climatico, conflitti bellici e tensioni internazionali hanno inciso sulla propensione ad avere un figlio anche nelle famiglie in cui sussistano sia il desiderio che la sicurezza economica”.
“Per questo – conclude Guetto – oggi la sfida più grande per chi decide le politiche pubbliche è offrire stabilità e prospettive. Le nostre ricerche confermano che soluzioni puramente ‘pro-nataliste’, come i bonus economici alla nascita, funzionano poco. Al contrario, sono le politiche di conciliazione famiglia-lavoro e gli interventi strutturali che favoriscono l’accesso alla casa e a un lavoro stabile e ben retribuito a creare davvero le condizioni – e la fiducia – per diventare genitori”.