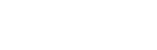Il contributo positivo delle scoperte scientifiche e tecnologiche sulla qualità di vita dell’uomo nella seconda metà del XX secolo è confermato da vari parametri qualitativi e quantitativi tra cui l’aumento della vita media, la ridotta mortalità infantile, le abitudini di vita e il benessere favorito da disponibilità di materiali e mezzi di comunicazione.
Accanto agli aspetti positivi di questo sviluppo tecnologico e industriale sono però sempre più evidenti gli effetti negativi sullo stato generale del nostro pianeta. Significativo è la definizione dell’epoca geologica attuale come “Antropocene”, l’epoca umana, nella quale, infatti, lo stato del pianeta Terra è fortemente influenzato dall’azione dell’uomo.
La criticità delle variazioni climatiche e i conseguenti effetti negativi su specie animali e vegetali hanno aumentato negli ultimi decenni la sensibilità dell’opinione pubblica e del mondo scientifico verso i problemi ambientali. Numerose ricerche scientifiche e tecnologiche sono orientate allo studio di processi e materiali sempre più sostenibili ma spesso nei diversi paesi le scelte politiche ed economiche sono influenzate da giudizi non sempre sostenuti da idonei dati sperimentali.
Non abbiamo tuttavia molto tempo per correggere la rotta e sicuramente non abbiamo la possibilità di sbagliare le misure correttive. Quale è quindi la soluzione possibile per ripristinare un equilibrio ormai fortemente incrinato?
L’emergenza COVID-19 ha portato nella nostra società la consapevolezza della vulnerabilità e ha anche evidenziato le fragilità economiche e sociali. Nel contrasto tra le diverse esigenze che sono emerse in questo periodo ci sono anche alcune considerazioni che ci permettono di riflettere sulle soluzioni da perseguire per migliorare il futuro ambientale del pianeta.
Ci siamo trovati bloccati in casa, riducendo i consumi di carburanti per gli spostamenti come nessuna limitazione al traffico per inquinamento è mai riuscita a fare. L’effetto positivo del lockdown sull’inquinamento è stato evidenziato da analisi della qualità dell’aria e dell‘acqua di mari, laghi e corsi d’acqua. La riduzione dei consumi ha anche ridotto la produzione di alcune tipologie di materiali di scarto. Ma la fase 2 ci ha insegnato che non è possibile bloccare le attività produttive senza favorire altri problemi economici e ridurre la qualità della vita.
Un altro importante insegnamento che rimane da questo difficile periodo è l’esigenza di valutare in modo corretto l’utilità generale di materiali e processi tecnologici. Non è infatti possibile identificare materiali o tecnologie come positivi o negativi in assoluto ma è fondamentale ricercare sistemi produttivi e di consumo più corretti per ridurre l’impatto sull’ambiente. Infatti abbiamo accusato internet e i sistemi di comunicazione di alterare le nostre capacità di interazione sociale ma sono stati questi sistemi che in questo periodo di emergenza hanno favorito i nostri contatti personali e di lavoro. Abbiamo giustamente osservato in modo negativo la plastica che non adeguatamente gestita inquina il mare, i territori creando problemi a pesci o animali ma è proprio la plastica che ci permette di realizzare manufatti e apparecchiature risultate indispensabili in questo periodo di emergenza. Il tessuto non tessuto delle mascherine, i tubi dei respiratori e molti altri dispositivi sono realizzabili con sostanze polimeriche che l’uomo ha imparato a sintetizzare copiando i polimeri presenti in natura per cercare di ottenere proprietà simili o superiori a quelli dei prodotti naturali.
Ma sono realmente pericolosi per l’ambiente i polimeri? Esiste un modo migliore per utilizzare questi materiali senza perderne i vantaggi ma eliminando le criticità sull’ambiente? Possiamo migliorare l’impatto sull’ambiente utilizzando i biopolimeri?
La risposta a questi quesiti deve arrivare da una valutazione scientifica e tecnologica completa sul ciclo di produzione e vita di ogni prodotto. Molti materiali polimerici possono ad esempio essere recuperati al 100% in modo analogo a quanto viene fatto con il vetro ma con un consumo energetico nettamente inferiore.
L’obiettivo principale delle attuali e future ricerche sui materiali deve quindi concentrarsi su processi più ecosostenibili di produzione ma anche sui processi di recupero non solo dei prodotti polimerici ma di tutti i componenti degli scarti provenienti dalle nostre attività.
Il recupero di molti materiali utilizzati per la realizzazione di manufatti, batterie, PC, attrezzature varie, mezzi di trasporto etc è essenziale per ridurre l’impatto sull’ambiente ma anche per ridurre lo sfruttamento di risorse naturali e lo spreco di fonti energetiche.
Un’altra strada importante è la valorizzazione di biomasse di scarto per affiancare ai prodotti provenienti da petrolio nuovi materiali con qualità specifiche diverse e più facilmente biodegradabili. Questi materiali sono fondamentali per i manufatti usa e getta e per molti imballaggi ma non sempre un biopolimero rappresenta per l’ambiente la migliore soluzione. Per tutti i materiali è infatti necessario analizzare il sistema di produzione e il loro ciclo di vita completa per confrontarne i reali effetti sull’ambiente.
La ricerca scientifica e tecnologica ha quindi oggi una grande sfida da affrontare in collaborazione con altri attori importanti:
- il mondo politico che dovrà favorire con opportune leggi il recupero e la valorizzazione degli scarti
- i cittadini che dovranno mostrare comportamenti responsabili favorendo il riciclo ed eliminando gli spechi.
La soluzione è quindi la ricerca di uno sviluppo sostenibile con l’obiettivo di mantenere il sistema produttivo essenziale nel rispetto dell’ambiente, della salute umana e delle esigenze delle generazioni future.
L’intervento di Antonella Salvini inaugura l’edizione 2020 di ScienzEstate, la manifestazione di divulgazione scientifica promossa da OpenLab: programma e attività sul sito, sul canale YouTube di Unifi e su Facebook