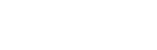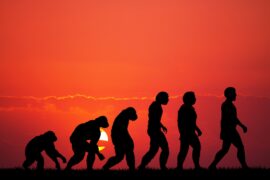Unifi ha partecipato a una ricerca internazionale che ha sequenziato i primi genomi antichi del cosiddetto “Green Sahara”, risalenti a 7.000 anni fa quando il più grande deserto del mondo era un ambiente umido simile a una savana.
Il team ha analizzato il DNA di due individui naturalmente mummificati, scoperti nel Sahara, nel rifugio roccioso di Takarkori, nel sud-ovest della Libia, dalla missione archeologica della Sapienza Università di Roma. La ricerca pubblicata su Nature è stata coordinata dal Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology di Lipsia (“Ancient DNA from the Green Sahara reveals ancestral North African lineage”).
Secondo lo studio i due individui (facenti parte di un gruppo di pastori) appartenevano a una linea umana nordafricana a lungo isolata e ora estinta, che aveva solo una minima componente genetica non africana: questo dato suggerisce che l’allevamento di bestiame potrebbe essersi diffuso nel “Green Sahara” attraverso lo scambio con altre culture piuttosto che per migrazioni di grosso impatto.
Inoltre, i genomi antichi non mostrano tracce di ascendenza subsahariana: ciò indica che, contrariamente a precedenti interpretazioni, il “Green Sahara” non era un corridoio che collegava il Nord Africa con l’Africa subsahariana.
Lo studio fornisce nuove informazioni cruciali sul Periodo Umido Africano, una fase compresa tra 14.500 e 5.000 anni fa, durante la quale il Sahara era una savana verde ricca di specchi d’acqua, e permetteva l’insediamento umano e la diffusione del pastoralismo. La successiva aridificazione ha trasformato questa regione nel più grande deserto del mondo, dove la conservazione del DNA è scarsa e ciò rende questa ricerca pionieristica ancora più significativa.
Le analisi genomiche rivelano che gli antenati degli individui di Takarkori discendevano principalmente da una linea nordafricana che si separò dalle popolazioni dell’Africa subsahariana circa nello stesso periodo in cui le linee umane moderne si diffusero fuori dall’Africa, circa 50.000 anni fa. Questa linea genetica, ora estinta in forma pura, rimase isolata per millenni, mostrando una profonda continuità genetica nel Nord Africa durante il tardo periodo glaciale. Tuttavia, la sua eredità genetica è ancora presente nella popolazione nordafricana odierna.
Inoltre, gli individui studiati condividono stretti legami genetici con i cacciatori-raccoglitori vissuti 15.000 anni fa nella grotta di Taforalt, in Marocco, associati all’industria litica iberomaurusiana, che precedette il Periodo Umido Africano: anche questi ultimi sono lontani dalle linee genetiche dell’Africa subsahariana. Entrambi i gruppi sono equidistanti dalle linee genetiche dell’Africa subsahariana, suggerendo che, nonostante la “rinascita verde” del Sahara, il flusso genetico tra il Nord Africa e l’Africa subsahariana rimase limitato.
Lo studio offre, inoltre, nuove informazioni sull’ascendenza neandertaliana, rivelando che gli individui di Takarkori possedevano una quantità di DNA neandertaliano dieci volte inferiore a quella delle popolazioni non africane, ma superiore a quella degli africani subsahariani contemporanei.
“I nostri risultati suggeriscono che, sebbene le prime popolazioni nordafricane fossero ampiamente isolate, esse acquisirono tracce di DNA neandertaliano attraverso un flusso genetico proveniente dall’esterno dell’Africa”, ha affermato Johannes Krause, autore senior e direttore del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.
“La nostra ricerca mette in discussione le precedenti ipotesi sulla storia della popolazione nordafricana e dimostra l’esistenza di una linea genetica profondamente radicata e a lungo isolata”, ha dichiarato Nada Salem (Max Planck Institute), prima autrice dello studio. “Questa scoperta ci aiuta a comprendere come il pastoralismo si sia diffuso nel ‘Green Sahara’, probabilmente più attraverso scambi di culture che attraverso migrazioni su larga scala”.
“Lo studio evidenzia l’importanza del DNA antico per ricostruire la storia umana in regioni come l’Africa centrale e settentrionale, fornendo supporto indipendente alle ipotesi archeologiche”, ha aggiunto David Caramelli, autore senior e antropologo dell’Università di Firenze.
“Esplorando il passato profondo del Sahara, vogliamo ampliare la nostra conoscenza sulle migrazioni umane, i loro adattamenti e l’evoluzione culturale in questa regione chiave”, ha concluso Savino di Lernia della Sapienza Università di Roma.